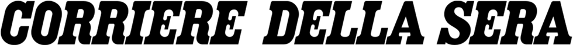Cop 30, uragani e riconversione delle spese militari
di Adolfo Santoro - Sabato 01 Novembre 2025 ore 08:00
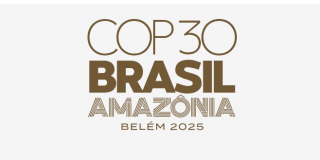
Tra il 10 e il 21 novembre prossimi si terrà a Belém, in Brasile - precisamente in Amazzonia -, la COP 30, che è la 30ª Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. È un incontro globale per discutere e negoziare azioni concrete contro il cambiamento climatico, in particolare a dieci anni dall’Accordo di Parigi (COP 21). I principali obiettivi includono il rafforzamento dell’ambizione per mitigare il riscaldamento globale, il progresso nell’adattamento, la mobilitazione dei finanziamenti climatici e la promozione della transizione energetica. Già nell’enunciazione di questi obiettivi si possono comprendere le difficoltà nell’assunzione di responsabilità da parte dell’Uomo verso le proprie sorti e verso quelle della Natura di cui dovrebbe essere il Protettore.
Alla Natura non resta che inviare all’Uomo quotidiani segni del sempre più insostenibile riscaldamento del clima: l’ultimo forte messaggio è stato l’uragano Melanie, che, dopo aver sventrato Giamaica,Haiti, Santo Domingo e Cuba, sta ora passando a devastare Bahamas e Bermude. La violenza di Melanie ha dato ragione allo studio, pubblicato nel febbraio 2024 sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da Michael F. Wehner e James P. Kossin, che proponeva l’introduzione di una Categoria 6 nella scala Saffir–Simpson per classificare gli uragani: Melanie ha superato i limiti superiori d’intensità di 310 km/h previsti per la Categoria 5, che fino ad allora erano ritenuti limiti difficilmente superabili.
La violenza di Melanie può influenzare gli equilibri del Mar Mediterraneo? Direttamente no, perché il Mar Mediterraneo è troppo piccolo e relativamente freddo per sostenere cicloni tropicali a piena intensità: eventi simili ai medicanes (Mediterranean hurricanes) sono molto più rari e più deboli (tipicamente di Categoria 1–2 equivalente), anche se alcuni modelli climatici suggeriscono che, a causa dei mari più caldi e della maggiore energia disponibile, i medicanes potrebbero diventare più forti, con venti più intensi e precipitazioni più concentrate. Ma, al di là degli effetti diretti, ci sono già effetti indiretti:
1. a causa delle connessioni a distanza le correnti atmosferiche vengono modificate dalla maggior frequenza e potenza degli uragani del Nord Atlantico e dei Caraibi, per cui i pattern di alta/bassa pressione che arrivano in Europa sono alterati, il che devia la posizione del getto polare e delle depressioni del Mediterraneo; ciò comporta un maggior rischio di alluvioni/piogge localizzate in estate/autunno e un maggior rischio di prolungata siccità in primavera/estate (il che consiglierebbe la raccolta delle acque nei periodi delle piogge!) per lo stabilizzarsi degli anticicloni nel Mediterraneo e di ondate di caldo;
2. a causa dell’aumento della temperatura superficiale del Mediterraneo aumenta l’evaporazione e, quindi, l’umidità atmosferica, che dà più energia ai temporali/medicanes; ne conseguono l’aumento del rischio di spiaggiamento delle praterie di Posidonia, l’aumento delle specie provenienti dai Tropici, l’alterazione della salinità e la stratificazione verticale dell’acqua (per cui i diversi strati non si mescolano più così facilmente);
3. si hanno conseguenze anche sulla terraferma: l’aumento di precipitazioni intense può aggravare il rischio di alluvioni e frane; i periodi più secchi combinati con ondate di calore aumentano il rischio di incendi boschivi e lo stress idrico; l’alternanza tra eventi estremi (pioggia e siccità) riduce la resa di colture tipiche mediterranee (vite, ulivo, ortaggi); il mare più caldo e le tempeste più forti accelerano l’erosione delle coste e mettono a rischio i porti.
Ma in Italia e nel mondo occidentale la notizia di Melissa ha faticato ad arrivare sui quotidiani, soprattutto in quelli coerenti con l’ideologia populista del negazionismo climatico. Così come è mancato l’allerta arancione per il prolungato temporale del pistoiese, che ha determinato allagamenti: tutto rientra nella normalità! Per i populismi vale la verità percepita dai media faziosi e dal popolo manipolato! A questo proposito è esplicativo il racconto breve, che Rudyard Kipling scrisse nel 1917, Il villaggio che aveva votato che la Terra è Piatta, in cui i protagonisti ingannano gli abitanti di un villaggio facendoli votare che la Terra è piatta. È una storia satirica in cui i protagonisti, per vendicarsi di un torto subito, escogitano un piano ingannevole: creano una finta società chiamata Società Geoplanaria e convincono gli abitanti del villaggio a votare una mozione che neghi la sfericità della Terra. Allo stesso modo i populisti, eletti da una minoranza di persone arrabbiate/impaurite, impongono per decreti legislativi le loro false verità alla maggioranza di chi non va a votare, alla più esigua minoranza di oppositori e all’ancora più sparuta minoranza di giudici e giornalisti che cercano di fare onestamente il proprio mestiere: la legge va sovvertita per legge! Il partito di Calenda ha proposto un disegno di legge per modificare l’articolo 61 della Costituzione: in base a presunte irregolarità durante la campagna elettorale, identificate come ingerenze straniere, diverrebbe possibile interrompere il processo elettorale, annullare il voto e farlo ripetere! Ma la Natura non tiene conto delle leggi degli uomini, che così ignorano la realtà della realtà e si rifugiano in una finzione alienata.
Questa ignoranza umana determina la competizione tra la sicurezza convenzionale (armi che derivano la loro energia di costruzione dal fossile, guerra mascherata da difesa) e la sicurezza climatica/ambientale: le spese militari sono risorse poco trasparenti che non vengono investite in altri settori, come la transizione energetica, le infrastrutture rinnovabili e l’adattamento climatico; se i Paesi della NATO raggiungessero l’obiettivo di spesa del 2% del PIL, molti trilioni di dollari sarebbero dirottati dalle attività di pace e dalla lotta al cambiamento climatico. La sparuta minoranza degli oppositori comprende gli attivisti di Greenpeace Italia, che hanno srotolato un mega-scontrino sulla scalinata di Trinità dei Monti, a Roma; nel mega-scontrino era scritto: È il prezzo che paghiamo per la crisi climatica ed erano annotati l’elenco di eventi climatici estremi verificatisi negli ultimi dieci anni, dall’accordo di Parigi a oggi, e una stima dei costi che la collettività sta già pagando e pagherà; il totale del conto presentato supera la cifra di 5.000 miliardi di euro (nel 2026 la spesa militare italiana aumenterà di un miliardo e nei prossimi tre anni sono previsti altri 23 miliardi!); 5.000 miliardi è pari al danno economico associato a sei delle più grandi aziende dei combustibili fossili al mondo, per cui gli attivisti richiedono una giusta tassazione per i colossi petroliferi.
Ma come stanno le cose? Se gli investimenti e la ricerca scientifica in armamenti degli ultimi cinque anni fossero stati destinati alla formazione della prossima generazione ed al progresso in fotovoltaico, a che punto saremmo ora?
Se ci basiamo sui dati SIPRI, la spesa militare tra il 2020 e il 2024 è stata di circa 11,6 trilioni di dollari; secondo dati IRENA, il reinvestimento di tali somme avrebbe comportato il raddoppio o la triplicazione del parco fotovoltaico mondiale entro il 2030, mentre con centinaia di milioni o con qualche miliardo per anno si riuscirebbe a pagare docenti, costruire scuole, programmi di formazione professionale, borse di studio su scala e la prossima generazione potrebbe ricevere, se i fondi fossero usati bene, una trasformazione sistemica dell’istruzione.
La Società Umana avrebbe una possibilità di sopravvivere alla catastrofe incombente. Ma, se la Società Umana ha già imboccato la strada dell’economia di guerra, come si possono trasformare le spese militari in investimenti civili (green, educazione, infrastrutture, energia rinnovabile, tecnologie riconvertibili)?
I principi guida di tale trasformazione sarebbero:
a) offrire scelte economicamente attraenti per favorire la conversione, ma usare anche leve contrattuali dove la spesa pubblica lo consente;
b) proteggere posti di lavoro e competenze (riqualificazione, sussidi temporanei);
c) riprogrammare l’offerta industriale e creare domanda civile (procedure attraverso cui le amministrazioni pubbliche acquistano beni e servizi tenendo conto di criteri ambientali, oltre che di qualità e prezzo).
In questo modo, ad esempio, la produzione di veicoli blindati potrebbe essere riconvertita in autobus elettrici e mezzi di trasporto pubblico (riuso dei processi di saldatura, carrozzeria, elettronica); la componentistica elettronica militare potrebbe essere riconvertita in inverter, controller e sensori per energie rinnovabili/industrie; i sistemi radar potrebbero essere riconvertiti in sensori agricoli e monitoraggio ambientale (monitoraggio coste per prevenzione inquinamento e erosione); gli stabilimenti di additive manufacturing (stampa 3D per difesa) potrebbero essere riconvertiti nella produzione rapida di componenti per turbine eoliche, protesi, parti medicali.
È utopia? Sì, ma solo partendo dall’utopia possiamo restituire la vivibilità della vita sulla Terra all’Uomo! E forse l’utopica base di partenza è far pagare le tasse a chi produce armi e a chi genera CO2 e metano in atmosfera!
Adolfo Santoro