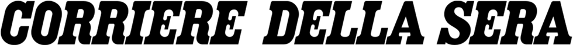Trump aspirante Messia in Medio Oriente
di Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi - Martedì 16 Maggio 2017 ore 08:00

Il 28 marzo del 1988 in piena Prima Intifada palestinese, uno dei massimi esponenti della nascente Hamas, Mahmoud A-Zahhar, venne “invitato” ad incontrare l'allora ministro degli esteri israeliano Shimon Peres, il quale era intenzionato a risolvere rapidamente la questione della protesta palestinese. Il cofondatore dell'organizzazione terroristica e un padre della patria, un fondamentalista islamico e un sionista, due nemici sedevano allo stesso tavolo di scambio, confrontandosi per la prima volta. Il palestinese offriva la pace in cambio di: fine dell'occupazione, ritiro da Gaza e West Bank, libere elezioni. Peres rispose in modo secco accettando l'azzardo: ci possiamo ritirare da Gaza subito, ci servono sei mesi per lasciare la West Bank e su Gerusalemme rinviamo la questione. A quel punto A-Zahhar avrebbe rifiutato l'ordine cronologico dei punti incalzando con “Jerusalem should be first”: Gerusalemme al primo posto. E ovviamente quel timido tentativo d'incontro, la prima “apertura” islamista ad Israele o viceversa fallì. Dopo poco Peres e Yitzhak Rabin apriranno un credito ad Arafat, si costruirono gli accordi di Oslo.
Poi arrivò la seconda Intifada e tornò la guerra. Tre decenni dopo quell'incontro “obbligato” il capo politico dell'organizzazione terroristica palestinese Khaled Mesh'al (tra i pochi ad essere sfuggito alla caccia del Mossad) annuncia, con enfasi e ampia copertura mediatica, una nuova storica pagina per il movimento prima di passare il testimone a Ismail Haniye. Dichiarando che Hamas non è il braccio operativo palestinese dei Fratelli musulmani, smarcandosi clamorosamente dalla casa madre e stendendo il tappeto al faraone al-Sisi. Annuncia inoltre che la Carta fondante del 1988 è superata: il Mithaq non è il Corano. E che i confini dello stato palestinese sono quelli del '67, prima della guerra dei sei giorni. Una smentita parziale, una policy volutamente ambigua nei rapporti con Israele e l'Occidente, ma anche un messaggio agli USA su eventuali segrete trattative da compiere nei prossimi mesi all'ombra delle piramidi.
Nel documento “programmatico” si spiega che la lotta continua, che non è una guerra di religione tra ebraismo e islam. Manca tuttavia il “tassello” del riconoscimento di Israele. “Fumo negli occhi” tagliano corto da Gerusalemme. Botta e risposta nel siparietto mediorientale che ha anticipato, e in parte condizionato, il vertice della Casa Bianca, di qualche giorno fa tra Trump e Abu Mazen: tra un presidente imprevedibile, talvolta impresentabile e ed un rais logorato, criticato e delegittimato. Un faccia a faccia poco proficuo e dai contorni vaghi. L'inquilino presbiteriano della Casa Bianca è “sentimentalmente” vicino a Netanyahu e appare totalmente indifferente al fatto che dall'eterno conflitto israelopalestinese emerga uno stato binazionale o due stati.
Il progetto a breve termine di Trump è scattare la foto con i due inossidabili leader che si danno la mano, in un gesto di apparente distensione. Strette di mano a parte l'imminente “pellegrinaggio” del neo presidente in Terra Santa potrebbe a catena avere effetti sulla maggioranza di governo di Netanyahu, risicata numericamente e condizionata da pulsioni nazionaliste. Mentre il reggente della Muqata ha uno spazio d'azione ridotto persino all'interno di Fatah (stretto tra le fazioni dell'esiliato Dahalan e quella di Marwan Barghouti, ancora chiuso, dopo le plurime condanne all'ergastolo, in un carcere israeliano). Abu Mazen frettolosamente ha firmato una cambiale in bianco a Trump, per limitare l'azzardo, in queste ore, ha cercato, e ottenuto, garanzia dallo zar Putin. Intanto, da una parte del muro e dall'altra, c'è già chi, in attesa di un suo tweet, elogia il chiomato magnate come un nuovo messia.
Leggi anche su www.ilmedioriente.it
Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi